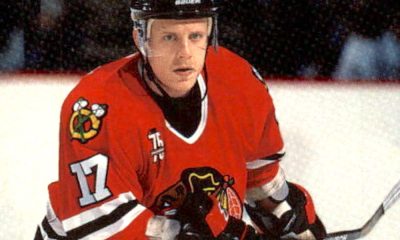Inizio febbraio 1960, nei corridoi della Blyth Memorial Arena di Squaw Valley in California si stanno definendo le ultime selezioni per gli imminenti Giochi Olimpici invernali. Un ragazzo della Minnesota University cerca il suo nome sulla rosa definitiva della squadra di hockey degli USA. Con l’indice fa passare la lista appesa al muro fuori dallo spogliatoio ma il suo nome non si trova e comincia a preoccuparsi.
Nel corridoio passa uno dei preparatori del comitato olimpico americano e il giovane lo ferma per chiedere se non ci fosse stato un errore. “Qual è il tuo nome ragazzo?”, Gli chiede il preparatore in tuta a stelle e strisce mentre tira fuori la sua cartelletta. “Herb Brooks, signore, università del Minnesota”. “No, mi dispiace ma non fai parte della squadra, sei stato tagliato. Non abbatterti, avrai altre occasioni”.

© usahockey.com
Metà febbraio 1960, pochi giorni all’apertura dei giochi nella località californiana. Coach Jack Riley, duro allenatore dell’accademia militare di West Point, ex pilota dell’aeronautica nella seconda guerra mondiale, è nella sua camera a studiare gli avversari grazie alle schede preparate sui giocatori avversari dai suoi collaboratori, che nel caso delle nazionali del blocco sovietico si sono affidati a veri e propri infiltrati in incognito.
I grandi favoriti sono Canada e URSS, con i sovietici detentori dell’oro conquistato nei loro primi giochi quattro anni prima a Cortina d’Ampezzo. Coach Riley si rende conto della forza di queste squadre di fronte a una formazione costituita perlopiù da universitari, agenti assicurativi, pompieri in congedo e carpentieri, ma è sicuro che con la preparazione fatta e il fattore casalingo anche i suoi ragazzi rientrano tra i favoriti per una medaglia.
Ma portare fin lì quella squadra non è una passeggiata, gli allenamenti militareschi e i modi duri di Riley hanno rischiato più volte di creare rivolte tra i giocatori, oltretutto pagati con un misero compenso di 7 dollari a settimana per piccole spese e farsi il bucato. Tagliando quelli che lui riteneva le mele marce e portando qualche giocatore disoccupato, magari dalle dubbie qualità tecniche ma a lui fedele riesce comunque a costituire un gruppo finalmente compatto.
Con il tifo del vice-presidente Richard Nixon dalle tribune, gli USA partono infatti bene nel girone preliminare, sconfiggendo la Cecoslovacchia per 7-5 e sommergendo l’Australia (ebbene sì, l’Australia) con un eloquente 12-1, qualificandosi come primi.

© usahockey.com
Il girone finale per le medaglie non è nel formato playoff, ma è un gruppo unico delle prime 6 qualificate che si scontrano una volta per definire la classifica finale. Gli USA dapprima fanno fuori abbastanza agevolmente la Svezia, mentre URSS e Canada rispondono con un 8-5 sulla Cecoslovacchia rispettivamente con un 12-0 alla Germania Ovest. Gli uomini di Riley hanno la meglio sui tedeschi con un chiaro 9-1 e si trovano quindi ad affrontare il Canada per una partita che garantisce in pratica l’accesso alla lotta per la medaglia d’oro. Gli americani hanno la meglio per 2-1 sul Canada davanti ai 9’000 entusiasti della Blyth Arena e rimangono quindi imbattuti a due partite dal termine del torneo.
Il 27 febbraio è la data fatidica, si trovano di fronte gli Stati Uniti e i favoriti sovietici allenati da Arkadi Chernyshyov, per trent’anni anche allenatore della Dynamo Mosca. La sfida viene trasmessa dalla CBS ed è in assoluto una delle prime partite di hockey trasmesse in diretta su suolo americano.
William Cleary porta in vantaggio inaspettatamente gli americani ma nel giro di cinque minuti i sovietici ribaltano il risultato. William Christian (il cui figlio David vincerà l’oro a Lake Placid) pareggia i conti a metà partita e poi a cinque minuti dal termine sigla la rete del 3-2 che regala il primo successo ufficiale degli USA contro l’URSS, vent’anni prima del miracolo di Lake Placid.
La Blyth Arena è in delirio, persino il presidente Eisenhower, presente in tribuna con il suo vice Nixon, fatica a contenere l’entusiasmo, ma i sovietici dimostrano una grande sportività nei confronti dei loro avversari, stringendone la mano uno a uno, un’usanza che nell’hockey americano ancora non esiste all’epoca, lasciando gli avversari di stucco. Persino Chernyshyov si lascia andare a complimenti inaspettati, abbracciando Riley negli spogliatoi e dandogli un bacio sulla guancia in pieno stile russo. Il primo miracolo, quello dimenticato, si è appena avverato.
Nell’ultima partita contro la Cecoslovacchia, in programma alle 8 del mattino del giorno seguente, ai ragazzi americani basterebbe un pareggio per aggiudicarsi la medaglia d’oro, ma dopo uno scoppiettante primo tempo chiuso sul 3-3, i cecoslovacchi si trovano in vantaggio per 4-3 a un tempo dal termine. Leggenda vuole che nella seconda pausa, il capitano sovietico Sologubov (nella pista in attesa di giocare qualche ora dopo) vede i giocatori degli USA letteralmente devastati nello spogliatoio e gli consiglia, facendosi capire a gesti, di inalare un po’ di ossigeno per riprendersi.
La cosa evidentemente ha successo, dato che gli americani nel terzo tempo segnano ben 6 reti in meno di un quarto d’ora contro gli esterrefatti uomini di Eduard Farta, ribaltando il risultato e aggiudicandosi l’oro in uno stadio delirante di gioia. La squadra di universitari, pompieri e assicuratori di Jack Riley vince la medaglia d’oro nei Giochi Olimpici in casa propria, un’impresa incredibile che è rimasta un po’ nell’ombra rispetto ad altri successi.
Ma quali sono i motivi per cui questa vittoria e in particolare quella contro l’Unione Sovietica sono state un po’ dimenticate? Le ragioni principali sono sostanzialmente due: a quei tempi l’antagonismo tra USA e URSS nell’hockey non è ancora radicato, dato che le due nazioni si erano scontrate una volta sola in occasione dei giochi di Cortina con i sovietici alla loro prima partecipazione, e il fatto già descritto che gli USA non selezionavano giocatori professionisti accresceva un senso di sottovalutazione degli avversari.

© usahockey.com
In secondo luogo il formato dei tornei olimpici e mondiali non prevedeva una seconda fase a playoff per le medaglie, ma un girone unico a punti e questo non contribuiva a rendere certe sfide uniche. Sono infatti le Summit Series del 1972 a far scoprire la forza dell’hockey sovietico ai nordamericani e l’introduzione dei playoff nei grandi tornei ha definitivamente contribuito a fare di certe partite delle sfide che andavano oltre l’aspetto sportivo, con l’apice di Lake Placid del 1980, quando l’Unione Sovietica aveva nel frattempo vinto i quattro tornei olimpici dal 1964 al 1976 e si era finalmente guadagnata il rispetto (oltre che il timore) degli avversari occidentali.
Ma certi miracoli, anche destinati a restare un po’ più nascosti, non sono da meno a quelli più famosi, perché aggiudicarsi un oro olimpico, il primo per gli USA, battendo le più grandi potenze mondiali con una squadra di operai e ragionieri disoccupati non è proprio roba da tutti i giorni.
Coach Jack Riley, considerato il grande artefice di questo successo, è tornato a fare quello che faceva tutti i giorni, ossia allenare la squadra dell’accademia militare di West Point fino al pensionamento (sostituito in panchina dal primo figlio nel 1986, a sua volta sostituito dal fratello minore nel 2004) e venne introdotto nella Hockey Hall of Fame assieme a tutta la squadra olimpica del 1960.
Dai modi bruschi e schietti, come era abituato nell’accademia di West Point, Riley non fece nulla però per nascondere il disappunto su come il suo miracolo venne messo un po’ da parte rispetto a quello di Lake Placid: “Siamo stati i primi a battere i sovietici e i sovietici erano forti nel 1960 quanto nel 1980, se non di più”.